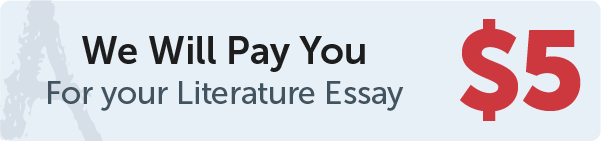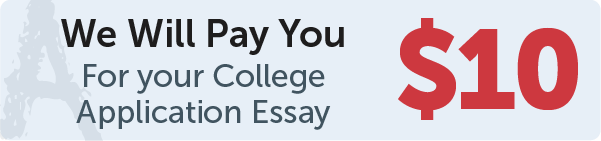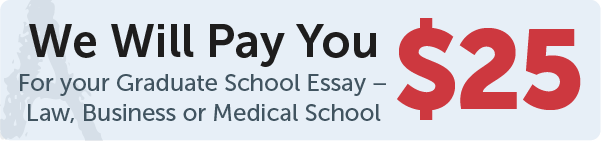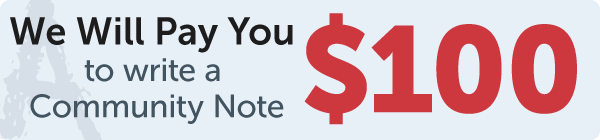Religione
L’opera propone un punto di vista critico sulla religione. I personaggi che fanno parte della Chiesa sono forse quelli la cui morale risulta più dubbia. Anche coloro che non ricoprono un incarico ufficiale all’interno dell’istituzione, sfruttano la religione a proprio vantaggio, motivo per cui perde autenticità e i vincoli con i veri valori cristiani.
Uno dei punti cardine delle riforme religiose che appaiono a partire da Lutero ed Erasmo è l’esercizio della religione in ambito privato. Durante il medioevo non esisteva una separazione tra pubblico e privato, ma a partire dalla forza che assume l’individualismo nel periodo del Rinascimento, i due mondi si separano e lo spazio privato è quello in cui l’individuo può davvero incontrare il divino.
L’influenza di Erasmo in Spagna è ampiamente documentata: i suoi scritti si diffusero rapidamente nel territorio e presto furono proibiti dall’Inquisizione. Per lui, la Chiesa promuove una pratica religiosa cerimoniale e superstiziosa che si contrappone al vero cristianesimo. Il cammino che propone Erasmo è l’esercizio privato della religione, in cui c’è spazio per un dialogo intimo con Dio, per una lettura personale delle Scritture e per l’imitazione degli insegnamenti del Vangelo nelle relazioni sociali. Il ricorso all’ironia e alla satira, in accordo al tono di Erasmo nei suoi scritti, fanno pensare che, nello scrivere l’opera, l’autore del Lazarillo avesse in mente le sue idee, soprattutto quelle esposte nel suo Elogio alla follia.
Nel Lazarillo de Tormes i personaggi che svolgono una funzione all’interno della Chiesa vivono la religione da un luogo che manca di autenticità. Il loro avvicinamento è addirittura mercantilista in certi momenti. Altri personaggi, come il mendicante, usano la superstizione e le suppliche anchilosate per lucrare.
Dal canto suo, Lázaro sembra stabilire una relazione privata con la religione, come quando parla di ricorrere a un’orazione segreta. Allo stesso tempo, nelle sue richieste a Dio si può notare un linguaggio piano, sprovvisto delle forme fisse o abituali delle suppliche. Ciononostante, Lázaro è lontano dall’essere un esempio di virtù perché molte volte le sue suppliche vanno contro i valori cristiani e cercano unicamente un vantaggio a suo favore.
La mobilità sociale
La capacità di migliorare la propria posizione economica o sociale è un punto cardine dell’opera. Anzi, il percorso che vive il protagonista è esattamente un cammino di miglioramento, in quanto riesce a trovare il suo posto all’interno della società a partire dagli insegnamenti che acquisisce nel corso della vita.
Nel Sedicesimo secolo la Spagna sperimenta una serie di cambiamenti nelle relazioni economiche, che la avvicinano a un sistema capitalista. Di conseguenza, il modello sociale chiuso e stazionario diventa aperto e competitivo, rendendo così possibile l’ascesa sociale. In ogni caso, l’opera ritrae un’epoca in cui convivono ancora i vecchi valori aristocratici conservatori con una concezione nuova in cui il merito personale può condurre a un miglioramento della propria posizione all’interno della società.
Rispetto ad altri paesi europei, la Spagna ha bisogno di più tempo per allontanarsi da un modello stazionario. In parte, la persecuzione degli ebrei contribuisce a dare valore al lignaggio perlomeno per quanto riguarda la purezza del sangue: è sufficiente dimostrare di essere un “cristiano vecchio” per poter partecipare ad attività produttive e far parte delle “empresas de conquista”. Senza dubbio non è una cosa da poco e per questo motivo si genera un vero e proprio commercio di documenti che certificano l’orgine. Allo stesso modo, la gran parte della società continua ad aggrapparsi ai costumi che stabiliscono che coloro i quali hanno un lignaggio nobile non devono svolgere lavori manuali, riservati invece per tradizione a ebrei convertiti o musulmani. Questo stesso settore della società mantiene valori aristocratici anacronistici che sembrano annullare o contraddire la possibilità di ascesa sociale.
Da un punto di vista aristocratico, Lázaro non riesce a migliorare la sua posizione perché sebbene sia innegabile il progresso della sua condizione economica, il disonore che lo avvolge (si dice che sua moglie sia l’amante dell’arciprete) nega la possibilità di una vera ascesa sociale. Per Lázaro, però, l’essere “cornuto” non annulla in alcun modo il suo cammino verso la cima.
La povertà
A partire dal Sedicesimo secolo le città diventano centri produttivi e i loro abitanti crescono rapidamente. Il modello capitalista richiede mano d’opera, cosa che contribuisce alla crescita della popolazione nei centri urbani. Questo porta alla nascita di un nuovo tipo di povertà, che si rivela talmente problematico in alcune città che lo Stato si vede obbligato a regolamentare la povertà.
Durante il medioevo, lo sguardo alla povertà era più benevolo dato che ai poveri era promesso il Paradiso. Inoltre, le classi sociali non permettevano al povero di cambiare la propria condizione. Tuttavia, a partire dai cambiamenti economici che rendono possibile l’ascesa sociale e richiedono mano d’opera, la concezione di povertà cambia. Nel Sedicesimo secolo, la mendicità era istituzionalizzata: coloro che non potevano lavorare, dovevano vivere delle elemosine e il resto della società se ne assumeva il peso attraverso la carità. Il mendicante non era indesiderato e la carità era un modo per dimostrare il proprio benessere economico oltre a essere un valore del cristianesimo. In altre parole, la relazione tra mendicanti e chi faceva carità era reciproca.
Ciononostante, la crescente povertà nelle città generò un nuovo tipo di mendicante, che non godeva dello stesso riconoscimento sociale. Si tratta dei “falsi mendicanti”, che simulavano malattie, si travestivano da pellegrini e cercavano di evitare il lavoro a ogni costo. Verso la fine del Sedicesimo secolo, il numero di mendicanti in alcune città era talmente elevato che si rese necessario regolare la mendicità attraverso licenze che consentivano a un numero ridotto di persone di vivere grazie alle elemosine. Gli orfani costituivano una grossa porzione della popolazione mendicante.
Tutto ciò viene rappresentato in modo realistico nell’opera. Il primo padrone di Lázaro è un cieco, un tipo di mendicante che godeva di particolare considerazione nella società. Lo stesso Lázaro, dal canto suo, inizierà a chiedere l’elemosina quando diventerà orfano di padre e sua madre sarà costretta ad affidarlo alle cure del cieco. Allo stesso modo, come già sottolineato, la storia del protagonista lo porterà ad ascendere socialmente e questi potrà esercitare, durante il suo percorso, i diversi uffici che il nuovo ordine sociale ed economico abilitava per persone come lui.
L'individualismo
I cambiamenti economici e sociali originano un nuovo valore: il merito personale. La concezione vitale che si inaugura nell’epoca pone al centro le libertà individuali, dato che la persona non è più determinata dalla gerarchia che ha ereditato, ma può trasformare la sua realtà a partire dalle proprie capacità. Allo stesso modo, la ripresa della cultura classica, che instaura l’umanesimo, mette l’uomo al centro e contribuisce a elevare la figura dell’individuo.
Tuttavia, l’individualismo e l’esaltazione della libertà personale non possono leggersi unicamente in chiave positiva. Non solo i propri meriti determinano il progresso, ma i propri peccati conducono alle difficoltà che l’individuo affronta. la coscienza della libertà personale rende ogni individuo responsabile delle sue azioni. In questo senso, Lázaro riconosce costantemente nel corso dell’opera i peccati di cui è colpevole e che lui considera essere la causa di gran parte dei mali che vive. In altre parole, l’individualismo porta a riconoscere il ruolo che ognuno gioca nel proprio destino, nel bene e nel male.
Si tratta di un’opera dalla finalità pedagogica; cioè, al termine della lettura, un lettore attento potrà trarre diversi insegnamenti. In accordo con l’individualismo come tema centrale dell’opera, uno di questi è la coscienza della responsabilità che ogni individuo ha nei confronti del proprio destino.
L'onore
Nel Sedicesimo secolo, in Spagna, una grossa porzione della società si trovava a metà strada tra le strutture organizzative della società medievale e il nuovo ordine che inizia a muoversi verso il capitalismo, dove impera la borghesia. Si tratta della figura dell’hidalgo, che a causa delle sue nobili origini non può lavorare per vivere, ma allo stesso tempo ha una funzione sociale e politica obsoleta. Quella parte della società conservava ancora i valori che risultavano antiquati e quindi, in un mondo in cui l’ascesa sociale e il merito personale hanno grande considerazione, l’hidalgo continua a dare importanza all’onore.
Perché il valore dell’onore dovrebbe essere antiquato o anacronistico? Principalmente perché si tratta di un valore radicato nel lignaggio. Basti pensare che in quel periodo, per paura della persecuzione di coloro che non potevano dimostrarsi “cristiani vecchi”, si falsificavano e addirittura commerciavano documenti che dimostravano una falsa origine, degradando così il valore del lignaggio. Dall’altro lato, serviva a poco essere di nobili origini se si riversava nella povertà e nell’inattività, motivo per cui i vecchi valori venivano messi in discussione, e tra questi anche l’onore.
Il romanzo rispecchia al trasformazione dei valori in una situazione congiunturale della storia della Spagna attraverso il contrasto tra due attori dell’epoca: uno che ha perso la propria validità e i cui valori non lo aiutano più a sopravvivere e un altro che è pienamente contemporaneo e la cui mancanza di valori consentono di trovare modi alternativi per prosperare. Si può affermare che Lázaro si trova in una posizione privilegiata rispetto all’onore, perché le sue origini non lo obbligano ad aggrapparvisi, perché è qualcosa di completamente estranea a lui. In altre parole, per Lázaro l’onore non è un problema perché l’alternativa è morire di fame. Nel romanzo, quella posizione “privilegiata” contrasta con ciò che succede a uno dei suoi padroni: lo scudiero. In quanto hidalgo, lo scudiero si trova in una posizione che richiede di evitare il disonore a costo di patire la fame.
Il relativismo morale
Questo tema è vincolato all’individualismo. Nel romanzo è presente una voce individuale egocentrica, che considera la sua storia personale importante e soprattutto essenziale per poter comprendere le sue azioni. Lázaro affronta qualsiasi giudizio si possa rivolgere alla sua condizione di cornuto raccontando le sue avversità, che a parer suo servirebbero a spiegare perché la sua situazione attuale sia fortunata.
Già nel primo capitolo, Antona, la madre, consiglia a Lázaro di “fare da solo”. Quel consiglio sembra radicarsi progressivamente in Lázaro e a partire dal Trattato Quinto, dimostrerà di aver imparato la lezione di tutti i suoi padroni, che lo hanno portato a cercare soltanto il suo interesse personale. Date le circostanze in cui vive Lázaro e dati i modelli che può seguire, la moralità di Lázaro non poteva essere diversa.
Tuttavia, il relativismo morale di Lázaro si estende ad altri. Il suo racconto ha l’obiettivo di spiegare come sia arrivato a una situazione favorevole pur intraprendendo azioni che sono senza dubbio discutibili. In ogni caso, sebbene Lázaro identifichi e critichi i vizi dei suoi padroni, non li condanna. Al contrario, apprezza ciò che ha imparato da loro anche se si tratta principalmente di lezioni sull’inganno e il tranello. Dal Trattato Primo, in cui Lázaro vede suo fratello allontanarsi da Zaide perché nero, senza sapere che anche lui ha le stesse origini, il narratore riflette con molta sensibilità sulla capacità altrui di vedere la pagliuzza nell’occhio del prossimo.
In questo senso, Lázaro agisce coerentemente perché così come si rifiuta di essere giudicato senza conoscere la sua situazione, non condanna gli individui. Le sue critiche più aspre sono rivolte al sistema a cui appartiene ogni padrone, soprattutto i primi tre. Del prete, per esempio, dice che è l’uomo più avaro che abbia mai conosciuto, ma poi spiega che è così proprio in quanto prete. Nel caso dello scudiero, la sua posizione indegna è prodotto dei valori ereditati. Lázaro considera che per giudicare un individuo sia necessario tenere in considerazione l’uomo e le sue circostanze.
Il cammino di apprendimento della vita
Nel romanzo, che prende la forma di un’autobiografia, i lettori accompagnano Lázaro nel suo percorso di trasformazione. Il suo sviluppo avviene attraverso una serie di esperienze che modificano la sua posizione di fronte a sé e di fronte al mondo. I lettori, in quanto tali, sono testimoni del cambiamento morale, psicologico, fisico e sociale che vive il protagonista.
La prima cosa che obbliga Lázaro a crescere è il prodotto di un’ingiustizia: all’epoca, per una madre vedova appartenente agli strati più bassi della piramide sociale, era quasi impossibile farsi carico dei propri figli. Questo obbliga Lázaro a vivere una separazione dalla sua condizione precedente, ad abbandonare ciò che conosce e assumere una posizione vulnerabile rispetto alla sua identità. Tutto ciò fa sì che Lázaro assorba ciò che vede intorno a sé e impari da quel mondo in cui viene gettato bruscamente.
Le difficoltà che affronta nei primi anni della separazione, in cui deve “fare da solo”, che tutte le sue energie sono rivolte alla mera sopravvivenza. La struttura economica e sociale lascia individui come Lázaro al margine, incompresi e relegati. Sotto queste condizioni, l’individuo dovrà conoscere sé stesso e costruirsi a partire da nient’altro che le proprie esperienze. I primi tre trattati sono i più importanti rispetto allo sviluppo psicologico, morale e sociale del protagonista.
Con il suo primo padrone, Lázaro impara quasi tutto ciò che serve per sopravvivere e inizia a usare l’inganno come sussistenza. L’apprendimento in questo primo trattato è chiaro perché, alla fine, con il colpo e l’inganno del cieco contro la colonna di pietra, il discepolo mostra di aver superato il maestro.Con il secondo padrone, il protagonista deve affinare i suoi inganni per far fronte a un antagonista che rappresenta una sfida più grande. Il prete è più crudele e, inoltre, ha tutti e cinque i sensi intatti. Il Trattato Terzo è determinante per la sua formazione morale, perché lo mette in contatto con valori che gli erano completamente sconosciuti, soprattutto l’onore. Il primo contatto di Lázaro con l’onore contrasta fortemente con ciò che ha appreso fino a quel momento, perché tutta la sua formazione ha avuto come obiettivo il superamento della fame e, improvvisamente, si trova di fronte a un uomo disposto a mettere a rischio la propria sussistenza per difendere l’onore.
Bisogna inoltre notare l’ironia che comporta il discorso della formazione in un personaggio che impara, attraverso l’esempio, l’arte dell’inganno, della truffa e dell’ipocrisia. Impara inoltre che è più importante l’apparenza dell’essere e, in particolare, che gli individui sono soli al mondo e devono “fare da soli” e preoccuparsi del proprio vantaggio. Dato l’ambiente culturale, sociale e morale che lo circonda, la formazione di Lázaro porta a una degradazione che lo porta a essere felice di essere arrivato all’apice della propria fortuna al prezzo di essere un cornuto.