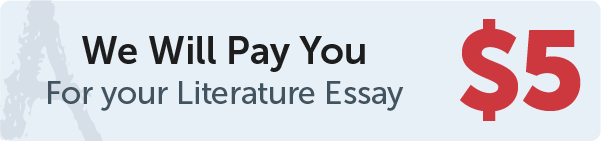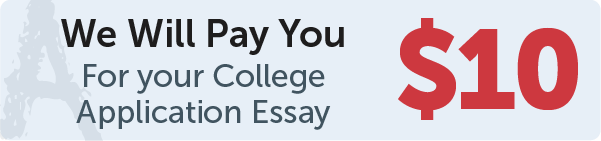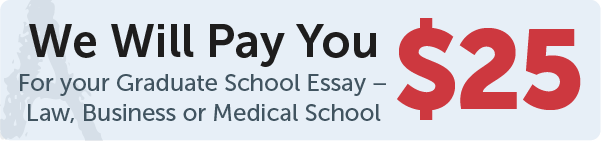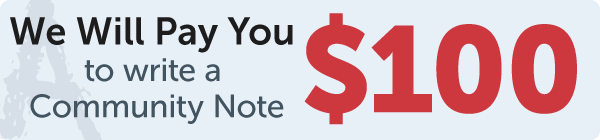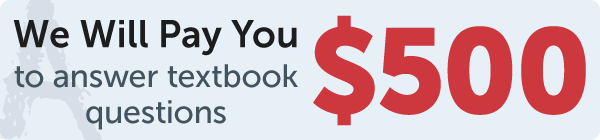Le corna (simbolo)
L’associazione tra le corna e l’infedeltà è comune, tanto che si è sempre utilizzata la parola “cornuto” per fare riferimento all’uomo la cui donna lo tradisce o si dice che “ha le corna”. La presenza delle corna nell’opera, soprattutto nel Trattato Primo in cui Lázaro è al servizio del cieco, anticipa la situazione in cui il protagonista si troverà quando scrive la lettera a Vossignoria: “il caso” a cui fa riferimento Lázaro nel Prologo gira infatti intorno alle dicerie riguardo sua moglie, che sarebbe amante dell’arciprete.
Essere e apparire (motivo)
La disparità tra l’essere e l’apparire viene duramente criticata nel corso dell’opera, soprattutto attraverso il valore simbolico degli abiti. Nel Trattato Secondo, Lázaro non sa se l’avarizia del prete sia una caratteristica personale o qualcosa che ha acquisito con l’abito talare quando è entrato nel clero. Il famoso detto “l’abito non fa il monaco” è qui rovesciato per fare una critica aspra nei confronti del clero come insieme. Secondo il romanzo, la maggior parte dei sacerdoti si comporta in modo immorale e le loro azioni risultano discutibili, tanto che sembrerebbe che far parte della Chiesa porti con sé una serie di vizi.
Il secondo momento dell’opera in cui l’abbigliamento ha importanza come elemento distintivo tra l’essere e l’apparire avviene nel Trattato Terzo, in cui l’aspetto rispettabile dello scudiero inganna Lázaro, che pensa di aver avuto un colpo di fortuna a incontrare un padrone aristocratico e probabilmente ricco. Nel corso del Trattato lo scudiero si prende cura con particolare attenzione dei suoi vestiti, si veste lentamente e si ferma ad ammirare parte del suo corredo. Ma dietro al suo aspetto non c’è alcun privilegio proprio della sua classe sociale: è un uomo più bisognoso di Lázaro, che almeno può chiedere l’elemosina senza conseguenze. Di nuovo, c’è disparità tra l’essere e l’apparire.
Nel Trattato Sesto, è Lázaro che presta attenzione all’abbigliamento perché per la prima volta può permettersi un corredo rispettabile. Ci sono dei parallelismi tra i modi in cui si presenta l’abbigliamento di entrambi, dello scudiero e di Lázaro, perché la descrizione si sofferma sul lavoro ammirevole delle spade. Lázaro avrà gli abiti prima ancora di avere la posizione sociale per cui sono richiesti e allo stesso tempo, una volta ottenuti l’abito e la sicurezza economica che cercava, non si preoccuperà più affinché dietro l’apparenza rispettabile ci sia un uomo degno d’onore. Al contrario, si accontenterà della ricchezza seppur procurata in modo umiliante.
Il vino (simbolo)
Il vino compare nella vita di Lázaro quando si trova a vivere le peggiori avversità e quando si trova all’apice della sua fortuna. Quando inizia a servire il cieco, Lázaro è ancora un bambino e sviluppa il gusto per il vino. Alcuni degli inganni più ingegnosi li concepisce con lo scopo di rubare al suo padrone un po’ di vino. Allo stesso modo, questa bevanda è causa di alcune delle sue peggiori punizioni: per esempio, Lázaro perde i denti quando il suo padrone scopre che beve dalla sua brocca attraverso un buco e lo colpisce con tutte le sue forze. Il cieco spiega il paradosso per cui il vino è sia ciò che lo fa star male, sia ciò che lo guarisce. Alla fine, questo paradosso si accentua ulteriormente quando migliora la sua posizione economica facendo pubblicità ai vini della città.
Quindi il vino è un simbolo delle avversità che fanno soffrire Lázaro, che in ultima istanza sono anche la sua salvezza, perché gli insegnano a rimettersi in piedi e sopravvivere.
Il cibo (motivo)
Nella prima parte dell’opera, il cibo riveste un ruolo fondamentale e diventa un motivo ricorrente. Soprattutto nei primi Trattati, la presenza del cibo appare secondo questo schema: Lázaro soffre la fame, ingegna un inganno per ottenere cibo, viene scoperto e subisce un castigo. La fine di questo ciclo corrisponde anche all’inizio di uno nuovo.
D’altra parte, il cibo rappresenta due elementi: la necessità e i vizi. Nel primo caso, le menzioni al cibo fanno riferimento alla necessità di Lázaro e all’ingegno richiesto per riuscire a soddisfarla. Allo stesso tempo, l’abbondanza di cibo o il fatto che possa considerarsi un lusso rappresentano i vizi di alcuni dei suoi padroni, come l’ipocrisia e l’avarizia.
Nella sua storia, fin dai primi anni di vita, Lázaro si è sempre sforzato di non morire di fame. Anche prima gli alimenti segnano la destinazione della sua vita: per esempio, sua madre deve trovare un modo per sopravvivere quando resta vedova, perché il padre di Lázaro è stato condannato per aver rubato della farina. Quando inizia a relazionarsi con Saide, lo schiavo nero, Lázaro non lo apprezza finché non capisce che ogni volta che va a trovarli, porta loro del cibo. Fin dall’inizio è quindi chiaro che il cibo guidi Lázaro non solo nelle sue azioni, ma anche nei giudizi che esprime.
Con il suo primo padrone, Lázaro inizia a sviluppare l’ingegno per poter mangiare di più e per poter godere di alcuni lussi come il vino e il salame. Con il secondo, invece, il suo ingegno deve acutizzarsi ulteriormente perché il prete lo lascia morire di fame. Infatti, Lázaro teme che le sue gambe dimagriscano per quanto è debilitato a causa dell’avarizia del suo padrone. Con il terzo padrone chiederà l’elemosina per sopravvivere. Nell’ultimo Trattato, l’arciprete regala, tra le altre cose, del grano alla coppia in cambio del loro silenzio e della partecipazione alla relazione immorale che la moglie intrattiene con Lázaro.
Il cibo è il motore che muove Lázaro e deve averlo segnato a tal punto che è disposto a sopportare qualsiasi umiliazione per non dover più soffrire la fame. Per questo, alla fine, non si preoccupa troppo delle malelingue: in sostanza è all’apice della sua fortuna e non dovrà più morire di fame.
L'ostia (simbolo)
Nell’opera si trovano menzioni dirette o più velate all’ostia sacra. In generale, quando si allude a essa, ciò che succede intorno a quest’oggetto sacro è un atto blasfemo. Al principio, quando Lázaro serve il cieco, prende le blancas (monete di scarso valore) in bocca, come se stesse prendendo l’ostia, per ingannare il cieco. Con il secondo padrone Lázaro ruba il pane che si prende come offerta in chiesa. Il trattamento che il prete riserva al pane è altrettanto discutibile.
Senza dubbio, oltre a tutte queste allusioni velate all’ostia che dimostrano un atteggiamento irriverente nei confronti dei simboli sacri della Chiesa, la menzione diretta dell’ostia nell’ultimo Trattato è quella che rappresenta maggiormente il degrado morale di Lázaro e il grado di cinismo che ha sviluppato. Tale cinismo si concentra nel discorso di Lázaro in cui dice di essere disposto a giurare sull’ostia consacrata per difendere l’onore di sua moglie quando è evidente che ci sia una relazione clandestina tra lei e l’arciprete.
In conclusione, l’ostia come simbolo del sacro, viene costantemente degradata dai personaggi che intervengono nella narrazione.