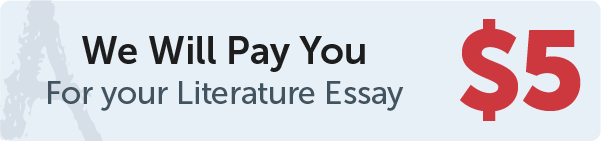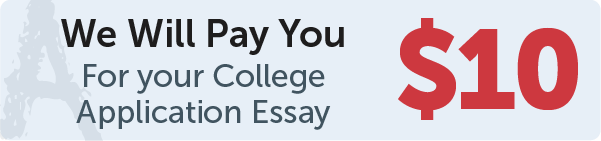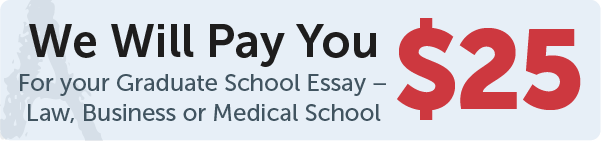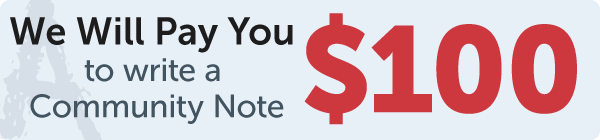Riassunto
All’inizio del Trattato Settimo Lázaro inizia a lavorare per l’alguacil, ma decide di lasciare l’attività perché la considera pericolosa, in quanto in alcune occasioni sono stati attaccati da delinquenti con bastoni e pietre.
Lázaro racconta a Vossignoria che desidera vivere con più tranquillità e risparmiare per la vecchiaia, ma ha anche la fortuna di ottenere un incarico reale, cioè un impiego nella burocrazia imperiale. L’incarico è quello del banditore, che consiste nel pubblicizzare i vini che si vendono in città e annunciare i delitti di coloro che sono perseguiti dalla giustizia. Racconta che una volta ha dovuto presenziare alla forca dove avrebbero punito un ladro, portando la corda. A questo punto del Trattato, Lázaro si discosta dal racconto per ricordare il cieco che, a Escalona a casa del calzolaio, aveva fatto alcune previsioni sul suo futuro che poi si sono rivelate corrette. Ricorda il suo padrone con gratitudine per avergli insegnato tutto il necessario per arrivare dove è arrivato.
Lázaro si rivela essere molto bravo nel suo lavoro e quindi l’arciprete di San Salvador gli propone di sposarsi con una delle sue serve. Lázaro accetta e dice di non essersi pentito della decisione: sua moglie è diligente e servizievole e l’arciprete regala loro grano, carne, pane e le sue calze vecchie, addirittura affitta una casa accanto alla sua dove loro possano vivere. Lázaro e sua moglie trascorrono quasi tutte le domeniche e le feste con l’arciprete.
Lázaro si sofferma sulle dicerie che riguardano sua moglie, sul fatto che vada e venga da casa dell’arciprete: non nega certi sospetti sulla donna, perché dice che più di una volta ha dovuto aspettarla fino all’alba. In quei momenti, Lázaro ricorda un’altra delle previsioni del suo primo padrone, il cieco, sempre a Escalona, quando prese delle corna e disse a Lázaro: “un giorno o l’altro questo coso che ho in mano ti farà andare per traverso pranzo e cena”.
Quando Lázaro espone i suoi dubbi all’arciprete, lui dice che per prosperare bisogna ignorare le malelingue e gli promette che sua moglie va e viene da casa sua senza compromettere l’onore di Lázaro. Egli risponde che i suoi amici gli hanno detto che sua moglie è rimasta incinta tre volte prima di sposarsi con lui e lei, che è presente, inizia a piangere e insultare l’arciprete. Insieme riescono a farla calmare e Lázaro promette di non parlare più di queste dicerie.
Poi Lázaro spiega che non ha mai più parlato del “caso” fino al momento in cui Vossignoria gli ha chiesto di parlarne. Davanti a tutti coloro che mettono in discussione la fedeltà della moglie di Lázaro, lui giura sul suo onore e sfida a duello chiunque dica il contrario. Lázaro conclude il suo racconto collocando i fatti nel tempo e assicurando che, in quel momento, si trova all’apice della sua buona sorte.
Analisi
Il Trattato finale mostra il risultato del percorso del protagonista: come conseguenza di tutte le avversità che ha dovuto affrontare, il suo istinto di sopravvivenza è l’unico valore che conta ed è sempre meno disposto a sopportare pericoli e peripezie. Quando percepisce che il lavoro con l’alguacil è pericoloso, lo lascia senza pensarci due volte. Nei primi Trattati Lázaro soffriva quanto i suoi padroni, ma qui fugge prima di venire raggiunto dai delinquenti. L’ironia è data dal dettaglio per cui Lázaro, dopo aver servito il cappellano, ha potuto comprarsi una spada, ma si tratta soltanto di un travestimento rispettabile, che non ha nulla a che vedere con il coraggio. Infatti, quando attaccato dai delinquenti, Lázaro fugge come un codardo. L’ipocrisia che si poteva notare in altri risulta ora evidente nel protagonista.
Il narratore ha un nuovo atteggiamento, che si è guadagnato poco a poco e che viene esplicitato nel secondo paragrafo, quando spiega che il suo desiderio è “avere un po’ di riposo e mettere da parte qualcosa per la vecchiaia”. Dopo tutte le avversità che ha dovuto affrontare, Lázaro vuole prosperare con l’astuzia e soprattutto con la fortuna. Il modo più semplice per assicurarsi da vivere è ottenere un incarico burocratico: qui si intende una critica sociale che mostra che gli unici che hanno un sostentamento sicuro sono i membri del clero e gli impiegati dello Stato.
Quando ottiene il lavoro di banditore grazie a un colpo di fortuna, la sua vita si trova nel punto più lontano rispetto alle sue origini. L’immagine di Lázaro che sostiene una corda per giustiziare un ladro fa ripensare a suo padre e al secondo compagno di sua madre, entrambi condannati per furto. Lázaro si trova ora nel ruolo opposto.
Il passo successivo che avvicina il narratore alla stabilità economica e sociale a cui aspira è il matrimonio con la serva dell’arciprete. Il sostentamento e la sicurezza che ottiene grazie a questa unione hanno un prezzo molto alto per il suo onore. Tuttavia, Lázaro ha sempre sofferto la fame e ha vissuto tante difficoltà e per lui il valore più importante non è l’onore ma il sostentamento. Lo sguardo critico dell’opera presenta una grande crisi morale: il nobile che dà valore all’onore e si aggrappa al passato muore di fame e vive di apparenze; colui che può prosperare con mezzi propri non può preoccuparsi né dell’apparenza né dell’onore. Fatta dall’arciprete, questa critica è ancora più chiara: “se uno sta a badare a quel che dicono le malelingue, non farà mai strada nella vita”. In una società ingiusta, l’unico modo di ascendere socialmente è farlo senza scrupoli e pensando solo al proprio beneficio.
Il degrado morale rappresentato nell’opera attraverso la vita di Lázaro si può sintetizzare nella risposta che lui dà all’arciprete: “ho deciso di trattare solo con le persone perbene”. Queste parole si ripetono due volte nel corso dell’opera: la prima fa riferimento alla situazione di sua madre, che una volta rimasta vedova deve trattare con persone perbene per sopravvivere. La parola “perbene” è usata in modo ironico: non indica un giudizio morale sulla persona, ma sulla sua situazione economica o sociale potenzialmente vantaggiosa dato che può approfittarsene come un parassita. Inoltre, l’espressione usata in lingua originale, cioè “arrimarse”, ha una connotazione sessuale: infatti sua madre avvia una relazione disonorevole e illecita e Lázaro accetta di essere cornuto e che sua moglie intrattenga una relazione con un sacerdote. Questo dimostra come il fulcro della moralità sia diverso da ciò che si intenderebbe normalmente: a essere perbene sono i ricchi e i potenti con cui i pícaros e gli ambiziosi possono trattare per prosperare.
La decisione di Lázaro di accettare la sua situazione e ignorare le malelingue è tanto ferma che è disposto a difendere l’onore di sua moglie commettendo un sacrilegio quando dice “sono pronto a giurare sull’ostia consacrata”. Bisogna inoltre ricordare che il “caso” di cui sta rendendo conto include anche una relazione illecita, dato che l’amante di sua moglie è un sacerdote. L’incisivo anticlericalismo dell’opera non poteva certo mancare nel Trattato finale.
Infine, è importante sottolineare il tema dell’individualismo legato alla moralità. Lázaro ritiene che il suo caso non possa essere giudicato senza conoscere tutta la sua vita. Fin dal principio, il protagonista insiste ad affermare che il suo racconto ha lo scopo di mostrare che coloro che hanno dovuto ingegnarsi per sopravvivere hanno più meriti di coloro che “hanno ereditato una nobile condizione”. Le malelingue, che discutono della situazione di Lázaro, desiderano misurare il suo stato con lo stesso metro con cui misurano gli uomini nobili, cioè l’onore. Tuttavia, per Lázaro il valore più importante è aver raggiunto la prosperità. I valori collettivi sono privilegi di coloro che sono legati dal lignaggio e dalla tradizione. Tutti gli altri devono cavarsela da soli e transitare ai margini di una società profondamente ipocrita e ingiusta.