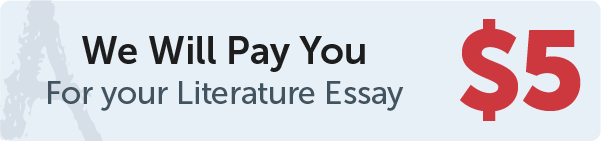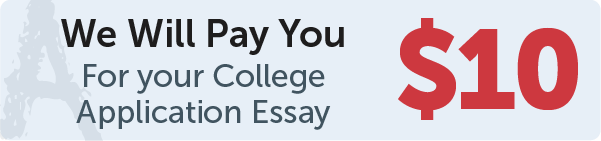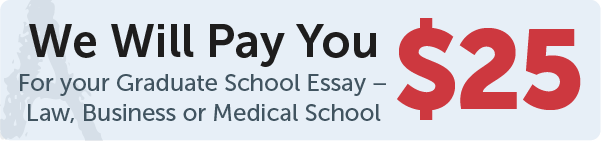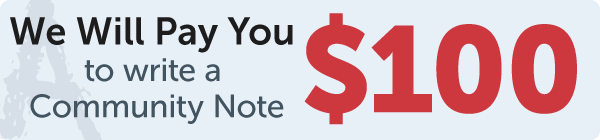Riassunto
Prologo
Víctor Goti, un personaggio dell’opera, è uno scrittore poco conosciuto a cui Miguel de Unamuno commissiona la scrittura del prologo di Nebbia. Questi inizia sottolineando che per lui le richieste di Miguel de Unamuno sono ordini imperiosi. Commenta poi la visione di Unamuno rispetto ad alcuni temi che si sviluppano nel romanzo. Inizialmente, parla della sottostima verso i lettori, sempre più frequente da parte degli scrittori, cosa che Miguel de Unamuno disprezza. Spiega inoltre la ricerca dello scrittore per mescolare commedia e tragedia in modo che arrivino a essere indivisibili. Infine, riferisce che per Unamuno l’umorismo deve necessariamente mettere a disagio e confondere.
Víctor conclude riguardo il finale del romanzo, spiegando che ha prove che dimostrano che Augusto Pérez si è suicidato e non è morto come riferisce Miguel de Unamuno.
Post-prologo
Miguel de Unamuno dichiara che si trova costretto a rispondere a Víctor Goti. Inizialmente gli recrimina di aver divulgato fatti espressi in forma privata, non con l’intenzione che venissero resi pubblici. In secondo luogo, esprime il fastidio che gli causa la sua posizione sulla morte di Augusto e lo minaccia di porre fine anche alla sua vita.
Capitolo I
Augusto Pérez esce a fare una passeggiata nel suo quartiere senza una destinazione precisa. Improvvisamente si rende conto di aver seguito una ragazza attraente. La giovane entra in una casa e Augusto chiede di lei alla portinaia dell’edificio, Margarita. Così scopre che si chiama Eugenia Domingo del Arco, che è nubile, orfana (vive con i suoi zii) e professoressa di pianoforte. Inoltre, Margherita gli spiega che Eugenia lavora perché la sua casa è ipotecata e Augusto conclude che probabilmente non sta passando un bel momento dal punto di vista economico. Quando se ne va, procede per il corso dell’Alameda, dove scrive e riflette su Eugenia. La ragazza gli ha provocato un forte impatto sebbene l’abbia vista di sfuggita. È inoltre ossessionato dal fatto che il suo nome sia Domingo: per lui dovrebbe chiamarsi Dominga. Alla fine, Augusto torna a casa.
Capitolo II
Augusto proviene da una famiglia ricca. Dato che i suoi genitori sono morti e non ha fratelli, possiede tutta la fortuna della famiglia. Vive con il servo, Domingo, e la cuoca, Liduvina. Augusto pranza pensando a Eugenia e cerca di evocare la sua immagine, riflette sul suo cognome, Domingo. Augusto scrive una lettera per lei in cui esprime il suo desiderio di conoscerla. Mentre va a consegnarla a Margarita, incontra Eugenia ma non nota la sua presenza. Al contrario lei si sofferma su di lui, che attira positivamente la sua attenzione. Augusto dà la lettera a Margarita e capisce che Eugenia ha un altro pretendente; ciononostante, non si lascia prendere dallo sconforto e decide di conquistarla. Poi va al casinò, dove incontra il suo amico Víctor per giocare a scacchi.
Capitolo III
I due amici giocano a una partita di scacchi, ma Augusto è talmente assorto nei suoi pensieri per Eugenia che non riesce a concentrarsi e perde. Víctor nota la sua distrazione e alla fine parlano del suo innamoramento. Augusto non sa nemmeno descrivere come sia Eugenia fisicamente, ma Víctor riesce a identificarla quando il suo amico spiega che dà lezioni di pianoforte.
Analisi
Nebbia è uno dei romanzi più conosciuti e probabilmente più acclamati dello scrittore e filosofo spagnolo Miguel de Unamuno. Scritto nel 1907 e pubblicato nel 1914, si tratta di un romanzo che rompe con il realismo letterario del XIX secolo e si trasforma in un tassello fondamentale per lo sviluppo del romanzo esistenziale e sperimentale del XX secolo. In questo senso, ci sono critici che indicano Nebbia come romanzo precursore e seme del postmodernismo, movimento culturale e filosofico che si consolida solo sessant’anni dopo la sua pubblicazione. La principale caratteristica di quest’opera in particolare, così come di tutta la creazione letteraria di Unamuno, è la fusione della filosofia con la narrativa.
Come punto di partenza, si potrebbe riassumere la trama con la seguente premessa: Nebbia racconta la storia di un personaggio, Augusto Pérez, perso nella “nebbia” della sua esistenza, che cerca di dare un senso alla sua vita. In realtà, non succede molto nella vita di Augusto Pérez, ma tutto ciò che gli accade serve come mezzo di riflessione per cercare di risolvere il conflitto permanente tra i suoi sentimenti e la sua razionalità. In questo modo, la poca azione che si svolge nel romanzo, ha la funzione di articolare e presentare al lettore diversi pensieri e dottrine filosofiche al cui studio Unamuno dedicò gran parte della sua vita. Tra questi si può sottolineare il senso dell’esistenza, l’ansia dell’eternità, la natura tragica della vita e la costituzione dell’identità in relazione al concetto di verità.
Come alcuni critici hanno sottolineato, Nebbia si può considerare un romanzo esistenziale, cioè uno scritto il cui tema principale è la costituzione dell’identità in relazione alla realtà. Augusto Pérez, il protagonista, vive una crisi esistenziale che lo spinge a mettere in discussione la realtà che lo circonda e la sua identità in quanto soggetto individuale e libero.
In questo senso, è importante sottolineare il carattere innovativo di Nebbia, perché l’opera si allontana dai romanzi realisti del XIX secolo che si interessavano alla descrizione del mondo come un insieme comprensibile in cui si muovono personaggi spinti da diversi motivi, in relazione con l’epoca e lo spazio in cui vivono. Nulla di tutto ciò si ritrova nella storia di Unamuno, che si concentra solo sullo spazio intimo dei personaggi. Così, Nebbia non espone una descrizione dell’epoca ma si focalizza sul riflettere lo stato di coscienza proprio degli intellettuali spagnoli al principio del XX secolo.
Un’altra novità presentata da Nebbia, in relazione con il romanzo realista tradizionale, riguarda la sua struttura narrativa: in primo luogo, l’opera è composta da trentatré capitoli dedicati al risveglio della coscienza di Augusto Pérez e alla sua morte, a cui si aggiungono due prologhi e un’orazione funebre che funge da epilogo. I prologhi sono, in realtà, parte del gioco narrativo sviluppato da Unamuno: uno di questi, il primo, è scritto da Víctor Goti, un personaggio del romanzo; l’altro, da Unamuno, in quanto autore del romanzo, però romanzato come personaggio all’interno dell’opera. Entrambi i prologhi hanno lo scopo di creare confusione nel lettore e contribuiscono a mescolare realtà e finzione all’interno del romanzo. Infine, l’orazione funebre: qui il narratore sfrutta la voce di Orfeo, il cane del protagonista, che lamenta la morte del suo padrone e riflette sulla natura umana.
L’azione di Nebbia si sviluppa in due spazi principali: la strada e le case di diversi personaggi, soprattutto quella di Augusto e quella di Eugenia. La strada è lo spazio aperto in cui Augusto si lancia nel cuore della sua crisi e dove sperimenta il mondo esterno a sé stesso, mentre le case rappresentano lo spazio di reclusione e chiusura, delle catastrofi personali e gli scandali. In questi primi capitoli, è la strada il luogo in cui Augusto si imbatte in Eugenia, di cui subito si innamora, mentre la casa si presenta come uno spazio di intimità in cui può consegnarsi ai suoi stati sognanti e costruire l’immagine personale di lei. Come spiega il narratore, Augusto “passeggiava nella vita” e per questo è la strada lo spazio in cui gli si presentano il mondo e le esperienze che fanno scattare il risveglio della sua coscienza. Su questo spazio, il narratore esprime con eloquenza: “Infatti la strada forma come un tessuto in cui s’incrociano sguardi di desiderio, d’invidia, di disprezzo, di compassione, d’amore, d’odio, vecchie parole il cui spirito rimane cristallizzato, pensieri, bramosie, tutta una tela misteriosa che avvolge le anime di coloro che passano”. Agli spazi ben definiti si aggiunge l’entrata e l’uscita di personaggi che danno vita a scene concrete, composte prevalentemente da dialoghi.
In questo modo la struttura di Nebbia si avvicina molto a quella di un’opera teatrale: in molti capitoli il narratore si limita a stabilire i parametri della scena, ma sono i dialoghi che fanno avanzare l’azione e la riflessione. Da questo deriva l’idea, che più avanti gli stessi personaggi dell’opera esporranno, per cui la parola vale più dell’azione, importa più ciò che si dice rispetto a ciò che si fa.
Come già menzionato, Nebbia è un romanzo che funge da scusa per lo sviluppo di una serie di riflessioni filosofiche. In questo senso, la sua struttura a dialogo si rifà in diverse occasioni al metodo socratico inteso come modo di cercare la verità filosofica di una questione in particolare. Il dialogo, o metodo socratico, presenta due o più interlocutori che a turno dibattono e realizzano congetture riguardo un tema di loro interesse e sul quale hanno idee o posizioni differenti. In generale, un interlocutore inizia ponendo una serie di domande che a loro volta suscitano altre domande da parte degli interlocutori e, successivamente, una serie di affermazioni su cui si costruisce gradualmente la conoscenza del tema affrontato. Quando il metodo si utilizza per sostenere un punto di vista, l’obiettivo di ogni interlocutore è far sì che il suo opponente si contraddica e quindi dimostri che la sua posizione è quella valida. Questo metodo è utilizzato in tutto il romanzo, soprattutto quando Augusto parla con Víctor, suo amico e filosofo che, come si vedrà successivamente, rappresenta in un certo senso lo stesso Miguel de Unamuno. Nel Capitolo III, durante il primo incontro con Víctor, si presenta la struttura dialogica che ricorda il metodo socratico:
«Ma dimmi, Víctor, la vita è un gioco o una distrazione?»
«Il gioco non è altro che distrazione.»
«Allora cosa importa distrarsi in un modo o nell’altro?»
«Perbacco, se si gioca, bisogna giocar bene.»
«E perché non giocar male? Perché non possiamo muovere questi pezzi in modo diverso di come li muoviamo?»
«Questa è la tesi, caro Augusto; come tu, quale tu, illustre filosofo, mi hai insegnato.»
Sebbene in questo frammento non si sviluppi l’idea, considerando che la conversazione riguarda l’innamoramento di Augusto, si può chiaramente vedere la struttura dialogica con cui nel corso dell’opera si sviluppano diverse questioni filosofiche.
Alle discussioni con altri, il narratore aggiunge lunghi monologhi in cui Augusto riflette sulla sua identità, sull’amore e anche sulla natura del mondo. È in uno di questi monologhi che il protagonista menziona per la prima volta la nebbia che dà il titolo al romanzo:
“Questa mia vita tranquilla, abitudinaria, umile, è un’ode pindarica tessuta con i mille nonnulla di ogni giorno. Le cose quotidiane! Dacci oggi il nostro pane quotidiano! Dammi Signore i mille nonnulla di ogni giorno. Noi uomini non soccombiamo alle grandi pene o alle grandi allegrie perché queste pene e queste allegrie sono avvolte in un’immensa nebbia di piccoli incidenti. E la vita è questo, nebbia.”
In questo passaggio, Augusto riflette sui fatti quotidiani e ripetitivi che costituiscono le basi della vita di ogni persona e indica che sono tutte quelle piccolezze abitudinarie a intrecciarsi fino a formare una nebbia che appanna la vista e confonde il soggetto. Questo suggerisce che la metafora della nebbia serve a esprimere un modo di essere al mondo, indifferenziato, confuso, anestetizzato dalla quotidianità che soffoca qualsiasi emozione forte. La nebbia verrà menzionata tante altre volte per approfondire il concetto e trasformarlo in una metafora sulla relazione del soggetto con la realtà che lo circonda.
Nonostante la sua densità concettuale, va segnalato che il tono di Nebbia è leggero e comico a tal punto che molti critici considerano l’opera una tragicommedia. In questo senso, sebbene Augusto finisca per suicidarsi, tutta l’opera si costruisce sulla base dell’umorismo e presenta caratteristiche proprie della commedia. Ciò risulta evidente fin dall’inizio, quando il protagonista si affaccia sulla strada prima di uscire: “Quando Augusto si affacciò alla porta di casa stese il braccio destro con la palma in giù e aperta, e volgendo gli occhi al cielo rimase un momento in questa posizione statuaria e augusta. Non era che prendesse possesso del mondo esteriore, osservava solamente se pioveva”. All’intermezzo comico di questa scena che ridicolizza la posa del protagonista, segue una riflessione che lo mette in ridicolo e lo presenta come un soggetto stravagante: “E non era che gli desse noia la pioggerella, ma il dovere di aprire l’ombrello. Era così elegante, così slanciato, piegato dentro la custodia! Un ombrello chiuso è tanto elegante quanto è brutto un ombrello aperto”. Forse il modo migliore di illustrare questo doppio gioco costante nella narrazione, che alterna umorismo e profonde riflessioni filosofiche, si trova nel nome del protagonista, Augusto Pérez: da un lato, “augusto” fa riferimento alla maestosità e all’eccellenza mentre dall’altro, il cognome “Pérez” (uno dei più frequenti nel mondo ispanico) fa riferimento a ciò che è banale, a quanto di più comune e quotidiano ci si possa aspettare. Come si vedrà nelle prossime sezioni, la dimensione umoristica del romanzo si esprime in una serie di situazioni che potranno considerarsi grottesche; cioè che tendono al ridicolo e allo stravagante e che aiutano il lettore a godere della lettura oltre il suo peso concettuale.