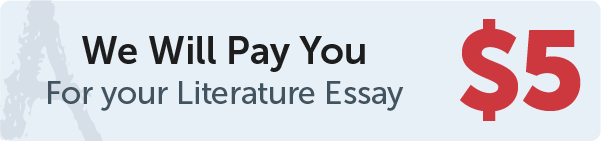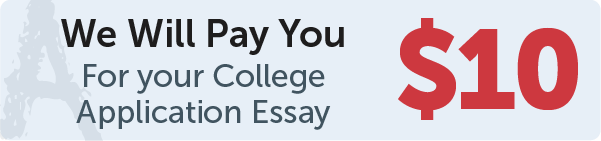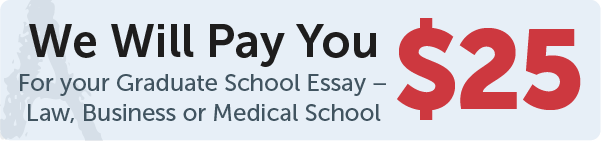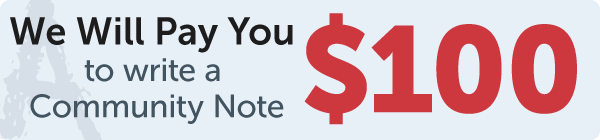Rifiuto del concetto tradizionale di identità
Sin dalle primissime pagine del romanzo, Pirandello mostra al lettore l’illusorietà della realtà causata dalla messa in discussione dell’oggettività delle conoscenze scientifiche. Egli non crede — o meglio non lo crede più dopo il 1904, con l’uscita del suo anti-romanzo di formazione Il fu Mattia Pascal — che la verità possa essere accolta dalla letteratura, condannando come menzogneri i codici espressivi del Naturalismo. Se attraverso Mattia si assiste a una prima dissociazione dell’io, si giungerà a una piena inabilità affettiva con Vitangelo, la cui condizione finale di non-vita è senza dubbio frutto di una congenita sfiducia che lo ha portato a disconoscere la realtà, rinunciando a qualsiasi suo aspetto. Vitangelo è spinto da una volontà di liberazione dalla “forma” e di scoperta del flusso della vita non in se stessi ma nell’adesione alla natura. Egli rifiuta l’identità sociale attribuitagli dagli altri e la moltiplicazione dei punti di vista, svelando la pervasività delle maschere.
Disgregazione dell’io
Rifugiando da qualsiasi comoda convenzione identitaria che potrebbe giovare la vicenda del giovane protagonista del suo romanzo, Vitangelo Moscarda, Pirandello gli fa pronunciare parole forti e feroci che voracemente annientano qualsiasi parvenza di oggettività. Difatti, anche i cosiddetti “dati di fatto” presentati all’interno della vicenda, come per esempio il giorno, il mese e l’anno della sua nascita, non concorrono affatto alla realizzazione e al raggiungimento di una verità incontestabile poiché questi suoi tratti sono sì peculiari ma malleabili alla realtà, continuamente cangiante, di altri esseri umani vanificando dunque qualsiasi tentativo di lettura unitaria. L’identità, sistematicamente messa in crisi all’interno del romanzo in quanto negata e rifiutata dal protagonista, è marchiata in quanto forma che arresta la vita, letale trappola che tende ad imprigionare ciò che per sua natura è libera e in continuo divenire. Esponendo il relativismo come unico punto di vista possibile dal quale tentare di sopravvivere al magma incoerente che è la vita di ognuno, Pirandello utilizza uno dei temi che più frequentemente compaiono nella sua produzione, letteraria e teatrale. L’unica soluzione percorribile è dunque uscire fuori dall’io, salvo presto comprendere come questo, a sua volta, è dilaniato, lacerato in tutta la sua integrità e fonte inesauribile di sfumature via via diverse e inafferrabili.
Incomunicabilità
La solitudine avvertita da Vitangelo e la sua incapacità di comunicare il proprio male agli altri, in quanto del tutto incapaci di ascoltarlo — tanto da richiedere l’interdizione ai primi segnali di aiuto manifestati dal protagonista — lo rendono affine all’afasia che caratterizza l’uomo nella moderna e capitalistica società volta al profitto. Il suo isolamento è paragonabile al processo di marginalizzazione al quale sono stati vittima gli intellettuali nel corso del XXI secolo, con riferimenti alla vicenda personale dell’autore che straborda i confini della realtà per invadere la pagina e influenzare i suoi eroi. Difatti, il processo di scomposizione dell’io che interessa Vitangelo, non rinvia ad una condizione patologica (come, ad esempio, una sindrome schizoide) ma a una condizione ontologica, pertinente all’essere-per-sé nel mondo.
Natura come alternativa al mondo della macchina
Dalla crisi d’identità al termine del racconto (ma non della storia poiché la vita non conclude), Vitangelo stigmatizza le convenzioni sociali, dando sostegno al panismo — laddove è chiaro il richiamo alla precedente cultura decadente e alla poetica dannunziana — in quanto abbandona la società per riconnettersi al flusso vitale della natura. Malgrado il desiderio di Vitangelo sia ritirarsi dalla società, incapace di comprendere il suo male in quanto sua causa scatenante, egli non si fonde con la natura in un rapporto paritario ma si annulla in essa, lasciandosi vivere nel flusso del vitalismo. Egli non ha più bisogno di un nome o di un’etichetta pronti a marchiarlo irreversibilmente ma solo mediante questa non-vita riesce ad esistere. Oltre a negare l’“uno”, così come Mattia Pascal aveva fatto dinanzi la sua tomba, affermando ormai di appartenere solo al passato, Vitangelo supera i “centomila” che hanno gremito la sua identità per rifugiarsi nello status di “nessuno”. Egli ormai vive “in ogni cosa”, avendo raggiunto il proprio annichilimento e la massima elevazione spirituale del sé, in fusione con l’ambiente naturale. La sua rinuncia alla forma significa anche rifiuto della città e della vita associata e comunitaria, a favore della solitudine che solo la campagna, in quanto garante dei valori propri di un paradiso primordiale contrapposto al caos della vita cittadina, percepita solo in lontananza col suono delle campane, può garantire. Per Vitangelo vivere significa ora non fermarsi mai, “rinascere attimo per attimo”: è possibile definire il finale della vicenda come positivo in quanto il protagonista ha finalmente ottenuto la pace e la completa soddisfazione che gli erano state negate nella vita precedente; tuttavia, come sovente in Pirandello, la suddetta vittoria è paradossale perché il costo pagato per raggiungerla è stato particolarmente alto, tanto da richiedere un identitario suicidio.