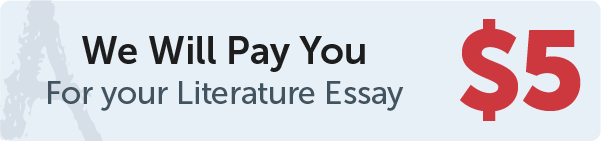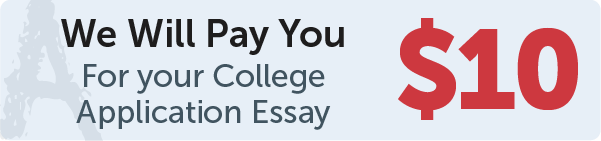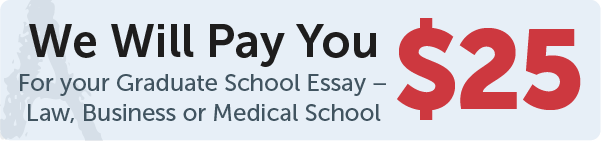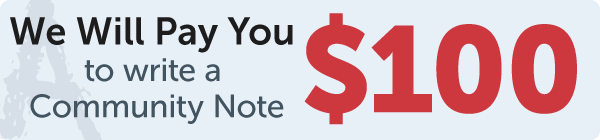L'aspetto umoristico
L’inizio in medias res del romanzo, con la domanda diretta “Che fai?” che Dida rivolge a Vitangelo, accuratamente intento a specchiarsi, rivela un procedimento narrativo tipicamente umoristico: un semplice e banale interrogativo diventa presto la scaturigine dell’intera storia, sorgente dell’infimo male che colpirà presto il protagonista. Il lettore si trova spiazzato dinanzi la reazione di Vitangelo, eccessiva rispetto all’intervento della moglie, e ciò provoca riso che, come sovente Pirandello è solito fare, diverrà amaro non appena le riflessioni profonde dell’uomo riveleranno una verità altra rispetto a quella convenzionalmente accreditata. L’intero romanzo deve essere infatti letto utilizzando contemporaneamente due livelli d’indagine: se inizialmente si è difronte al comico e al buffo — basti ricordare il battibecco che Vitangelo ha con la moglie, impegnata a elencare i suoi piccoli difetti fisici, o la discussione che ha con l’amico, il quale ribadisce la pendenza del suo naso e deride il suo stupore — lungo lo scorrere delle pagine il lettore è costretto a relazionarsi col senso di tragico che aleggia sull’intera vicenda e che innesca una rappresentazione della vita psichica individuale inquietante e di grande modernità, nella quale è ben ravvisabile la teoria psicanalitica.
Ad alimentare la raffigurazione del comico all’interno del romanzo è senza dubbio la scelta dell’autore di far condurre l’intera narrazione in prima persona dal protagonista narratore che, come già Mattia Pascal anni prima, manifesta la sua inaffidabilità rispetto al ruolo che è chiamato ad adempiere. Il patto di fedeltà narrativa, da tempo immemore siglato fra narratore e lettore, viene meno all’interno della frammentazione identitaria di cui è vittima l’uomo all’interno della società moderna. Le continue digressioni e i commenti sarcastici, talvolta crudeli, del narratore riguardo la realtà e il proprio io, ledono la secolare fiducia che convenzionalmente il lettore riversa nei suoi confronti. Tutti questi elementi, nuovi e confusi, concorrono a creare un generale disorientamento nel lettore, incapace di filtrare le informazioni veritiere, semmai ve ne siano all’interno della vicenda, tra le numerose riflessioni che il narratore riporta e che contribuiscono a definire quest’ultimo inattendibile. Che il comico sia pirandellianamente innanzi la tragedia, è ben sottolineato sin dalle prime pagine quando, al progressivo tormento di Vitangelo di fronte la vista del suo riflesso, Dida è rappresentata come mossa “placidamente” dal riso. Incapace di cogliere il male carnefice del suo coniuge, la donna è investita da numerose domande che, mediante l’omissione del soggetto parlante, le vengono rivolte dal protagonista (“Che altro?” oppure “Ancora?”), originando una dimensione interrogativa che caratterizza l’intera vicenda.
La continua interrogazione è un elemento che amplifica il tema del doppio, poiché presuppone due soggetti (il richiedente e l’interpellato), che all’interno del Libro Primo sono capillarmente scanditi dalle parole di Vitangelo il quale, attraverso un “voi dite” rivela come il soggetto interrogante, preda dell’intero suo monologo interlocutorio sia, sin da subito, il lettore tramite una tecnica compositiva dominante dell’intero romanzo in grado di associare al fruitore il ruolo di ulteriore specchio contro cui andrà a ispezionarsi e deteriorarsi la personalità del narratore. Il critico letterario Guglielminetti sottolinea l’importanza dell’uso, da parte del narratore, del pronome “voi” poiché dimostra: l’intenzione di Pirandello di coinvolgere attivamente i lettori all’interno della sua opera e la volontà di andare oltre il monologo interiore (per il quale qualsiasi riflessione sarebbe rimasta circoscritta al personaggio) per esibire un metodo d’indagine critico ed esemplare delle sue teorie estetiche.
Il testo umoristico dunque straripa e sconvolge tutte le forme, anche quelle proprie dei codici narrativi della scrittura romanzesca mostrando, ad esempio, come il titolo di un capitolo sia, in verità, la conclusione morale del capitolo precedente (è ciò che accade fra i capitoletti quinto e sesto del Libro Secondo) in un continuum narrativo incapace di concludersi, al pari del magma della vita.
Il romanzo può essere analizzato come messa a fuoco di alcuni dei punti cardine della narrativa pirandelliana che l’autore espone all’interno del suo saggio Umorismo (1908): è questo il luogo in cui, riflettendo sul rapporto che intercorre fra arte e artista nel mondo moderno, la visione tragicomica della condizione umana giunge a maturazione attraverso la differenza frapposta tra l’avvertimento del contrario e il sentimento del contrario. Il primo nasce dal contrasto tra apparenza e realtà che provoca generalmente un senso comico, un’ilarità talvolta maliziosa; il secondo concerne invece l’umorismo ed è uno stadio più profondo, bisognoso di una riflessione acuta che non fa altro che provocare un riso amaro e malinconico. L’umorismo ci consente dunque di scavare e rivelare le motivazioni che spingono gli individui a compiere atteggiamenti inopportuni, per i quali la sono empatia può causare una giustificazione (come esempio alla sua teoria, Pirandello riporta la vicenda del La vecchia imbellettata). All’interno del saggio, inoltre, Pirandello studia e discute il dualismo della vita e della forma, colpevole di ostacolare qualsiasi veritiero processo conoscitivo, incapace di superare le apparenze e il relativismo. Tra le fonti da annoverare per la formazione pirandelliana in tale direzione, è bene ricordare il Saggio sul genio nell’arte (1884) del filosofo francese Gabriel Séailles: nel testo l’autore afferma come l’essere umano non sia in grado di percepire le cose per come esse siano, ma solo di apprenderle soggettivamente per come esse appaiono, a seconda dell’educazione, della mentalità e della situazione in cui si è nel momento dell’incontro. Inoltre Pirandello ha acquisito, mediante gli studi del pedagogista italiano Giovanni Marchesini — raccolti nel saggio Le finzioni dell’anima (1905) — la certezza che, paradossalmente, nessuna certezza sia possibile: il bene, il male e i valori di lealtà, onestà e famiglia, non sono altro che costruzioni sociali che perdono tutta l’importanza che possiedono se posti all’interno di un microcosmo sociale diverso da quelli comunemente conosciuti. Non sono altro che forme, ovvero convenzioni che impediscono il libero scorrere del flusso vitale, accordato all’ambiente naturale. Dunque, sebbene Vitangelo possa apparire come una figura pars pro toto, abile a incarnare il dramma comune all’intera umanità, in realtà la sintassi adoperata all’interno del romanzo intende ovviare il timbro di denuncia e protesta - in un primo momento attributi al protagonista - in nome di valori umani generalmente condivisi. L’intera opera deve risultare come pronuncia di una voce singola, familiarmente e socialmente, emarginata cosicché la vena umoristica possa circondare l’intera vicenda, generando una malinconica sensazione di abbandono verso cui si troverà il diretto il lettore alla fine del testo.